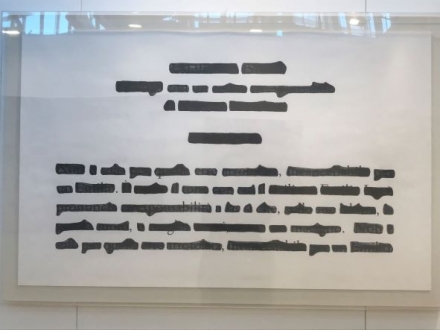His house
Un horror stratificato dalle molteplici letture. L'orrore vero è nel grigiore della vita quotidiana più che negli spettri figli dei sensi di colpa.

Disponibile su Netflix
Rial (Wunmi Mosaku) e Bol (Sope Dirisu) sono due profughi sudanesi, giunti in Gran Bretagna, ai quali, finalmente, viene assegnata un’abitazione affinché possano integrarsi e dimostrare la loro “buona volontà” in attesa del riconoscimento dello status di rifugiati. Ma tra quelle pareti c’è qualcosa che li perseguita.
His House, esordio nel lungometraggio di Remi Weekes, è un horror stratificato e dalle molteplici letture.
La prima questione riguarda ciò che realmente vuole la creatura che li perseguita.
Apparentemente l’essere ha significati diversi per i due protagonisti. Per Rial sembra indissolubilmente legato al suo ruolo materno, mentre per Bol appare piuttosto come la rappresentazione dei suoi sensi di colpa.
Ma c’è dell’altro; che cosa esattamente rimproverano le varie apparizioni alla coppia?
A seconda dei momenti le loro colpe appaiono diverse.
Così il loro peccato originale potrebbe essere quello di aver abbandonato la loro patria, ovvero la casa (home) per cercare altrove un’esistenza migliore in una nuova abitazione (house).
Sarà solo il dispiegarsi degli eventi e la svolta narrativa del film a gettare luce sul prezzo pagato dai due per raggiungere la salvezza, su ciò che hanno compiuto, in un certo senso il crimine di cui si sono macchiati.
Così, un po’ come accadeva in Babadook di Jennifer Kent, i fantasmi in realtà altro non sono che la proiezione del nostro inconscio, delle nostre paure e dei nostri peccati e l’unica soluzione per vivere tranquilli è, in qualche modo, venire a patti con essi, sconfiggerli, mutare di segno la loro essenza ed imparare a conviverci.
Questo però è solo uno dei temi messi sul piatto dal regista.
Dall’altro c’è la possibilità di una lettura più squisitamente politica.
Rial e Bol, infatti, sono dei rifugiati.
Portano con sé gli orrori vissuti sia in Sudan, sia durante il loro viaggio, eventi che, letteralmente prendono vita in alcune delle migliori sequenze del film, quelle ad esempio in cui, improvvisamente, la cucina dove mangiano diviene una barchetta spersa in mezzo al mare.
Immagini potenti nonostante l’evidente povertà di mezzi e gli effetti speciali non propriamente eccelsi.
Limiti che, per assurdo, esaltano il carattere visionario di queste allucinazioni.
Tuttavia, pur essendo profughi, i due protagonisti, che all’inizio sembrano vittime del sistema, ben presto rivelano un altro volto con una svolta narrativa geniale.
Rial e Bol sono anch’essi, a modo loro, dei carnefici, hanno compiuto un gesto orribile pur di salvarsi ed ora il peso di quella scelta è venuta a chiedere il prezzo.
Remi Weekes opta per una scelta incredibilmente coraggiosa ed invece di confezionare un semplice horror che sia un atto di accusa nei confronti dell’occidente ci presenta dei protagonisti ambigui ed anch’essi non privi di pesanti ombre.
Non c’è, insomma, una distinzione netta tra il bene ed il male.
Ognuno sembra costretto a scendere a patti con la realtà; la salvezza, come solitamente accade nei momenti tragici della storia, impone delle scelte dolorose, difficili e che, in condizioni normali, sembrerebbero eticamente sbagliate ma che, in quelle determinate circostanze, sono l’unica possibilità di salvezza.
Il tutto viene calato nella più classica delle strutture, quella della storia di fantasmi con un uso ampio, ma per fortuna ben calibrato, dei jumpscare.
In realtà, la parte più propriamente horror del film, è quella che forse appare meno solida.
Il regista dimostra un abile mestiere, però alla fine sono cose già viste migliaia di volte sullo schermo e complice un finale un po’ troppo frettoloso e semplicistico, non tutto funziona alla perfezione.
Forse Weekes avrebbe dovuto insistere di più sulla parte legata ai miti e al folklore africano, non solo per quanto riguarda la figura stessa dello spettro ma soprattutto per ciò che concerne le sequenze nelle quali Rial, improvvisamente, si ritrova catapultata in Sudan, momenti anch’essi dal forte impatto visivo, non solo per il senso di straniamento che provocano nello spettatore ma anche per la capacità che hanno di trasportarlo in ambienti onirici, dalle atmosfere quasi da “realismo magico” anche in virtù del contrasto con il resto della pellicola.
Ed è proprio nella descrizione degli ambienti che His house dà il meglio di sé.
Weekes ambienta il suo film in una periferia londinese, grigia, sporca, geometrica ed opprimente alla quale fa il paio la casa, anch’essa anonima, triste e grigia, assegnata alla coppia, piena di scadente carta da parati, dominata dal giallastro figlio dell’umidità che sembra trasudare dalle pareti.
Più che gli spettri che infestano l’abitazione sembra essere questo il vero orrore.
Quello fatto di palazzi sempre uguali, inquietanti e spettrali nei quali si perde Rial, con quel senso di angoscia e paura che la opprime e che è figlia tanto del razzismo che incontra quanto di quelle strade aliene ed alienanti, così lontane dai caldi colori africani e dalla loro terra rossa.
L’orrore, quello vero, è ritrovarsi in un anonimo centro commerciale a comprare i vestiti che si vede in fotografia nel disperato tentativo di omologarsi più che di integrarsi.
Forse non è un caso che l’agognata felicità abbia l’aspetto di volti familiari ed indossi sgargianti vestiti africani; il colore finalmente ha vinto sul grigiore e si può guardare con speranza al futuro senza dimenticare chi siamo, da dove veniamo ed il prezzo pagato.
EMILIANO BAGLIO